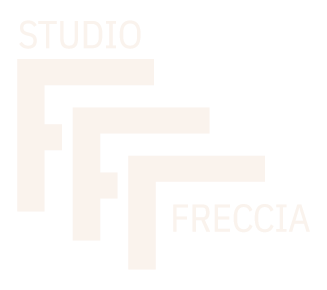- Il dettato normativo: aspetti generali e casi di applicazione.
L’istituto della c.d. MAP (Messa alla Prova) è disciplinato sia dal codice penale (artt. 168 bis, ter e quater) che dal codice di procedura penale (artt. 464 bis e seguenti).
Questo istituto, ispirato dal processo minorile, è stato introdotto anche per il giudizio ordinario nel 2014 con la Legge n. 67 con l’obiettivo di evitare la prosecuzione in giudizio di casi particolarmente bagatellari definendo il procedimento con la prestazione di lavori di pubblica utilità.
In particolare, ex art. 168 bis, comma 2, c.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova “comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”. Dunque, in maniera condivisibile ed in ottica deflattiva, il Legislatore ha deciso, che in particolari casi, è più conveniente dare, per così dire, una seconda possibilità al reo, sospendere il giudizio penale durante l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali ed estinguere il reato in caso di esito positivo della messa alla prova.
Ovviamente, vista la ratio assolutamente a favore dell’imputato dell’istituto, lo stesso può essere concesso esclusivamente in casi limitati, recentemente aumentati dalla riforma Cartabia: l’articolo 168 bis, comma 1, c.p. in questo senso sancisce i limiti, stabilendo che la MAP può essere concessa solo:
- per i procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p. (ovverosia i delitti per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio). Questa categoria di reati è stata oggetto di ampliamento da parte della riforma Cartabia.
Anche dal punto di vista soggettivo vi sono dei limiti poiché la MAP non può essere disposta più di una volta (su questo è intervenuta la Corte Costituzionale sancendo l’illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede la deroga per i reati connessi ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p.).
La recidiva, invece, secondo la Corte di Cassazione non può escludere automaticamente la concessione della messa alla prova (Cass. Pen., Sez. IV, n. 4526/2016).
2. Il procedimento per la concessione della MAP.
A livello pratico la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta dall’imputato – personalmente o con procuratore speciale – o dal Pubblico Ministero (questa è una novità della riforma Cartabia).
La richiesta può essere formulata, nei casi in cui è prevista l’udienza preliminare, fino a che non siano formulate le conclusioni e, negli altri casi, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale e comunque fino all’apertura del dibattimento.
A rigore di legge (art. 464 bis, comma 4, c.p.p.), alla richiesta deve essere già allegato il programma predisposto dall’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) competente: può essere utile osservare come nella maggior parte dei casi il programma verrà predisposto in concreto solo dopo l’ammissione del Giudice e su richiesta dello stesso.
A seguito della richiesta di ammissione, il Giudice, per l’appunto, valuterà se vi sono i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione stessa, a seguito della quale il procedimento verrà sospeso per il termine indicato dall’Autorità Giudiziaria.
Nel termine della sospensione l’imputato dovrà rispettare il programma predisposto dall’UEPE, ente che avrà cura di mandare costanti aggiornamenti all’Autorità Giudiziaria.
In caso di esito positivo della messa alla prova, il reato verrà dichiarato estinto dall’Autorità Giudiziaria.